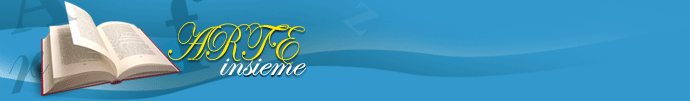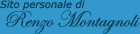L’Argia e Scatoletti, di Ernesto Flisi
L'Argìa e Scatoletti
di Ernesto Flisi
Questa è una storia di sopravvivenza, di due vite cominciate in salita e vissute sempre in salita. La loro esistenza non andrà mai sui libri di storia. Ricordare perciò queste due persone, oggi sembrerebbe senza senso, eppure qualche riflessione ce la forniscono, ma facciamo qualche passo indietro, nel secolo passato, a cavallo tra Otto e Novecento.
L'Argìa (o come tutti la denominavano, l'Argiòn, a motivo della sua corporatura, bassa e sovrappeso) e Scatoletti erano sposati, senza figli. Dell'Argiòn non si sa il cognome; com'era uso allora, era l'Argiòn di Scatoletti e basta. Scatoletti invece, piccolo, magrissimo, tutto nervi, veniva sempre chiamato col cognome, nessuno lo chiamava per nome. Insomma due persone che si compensavano: quello che aveva l'una, non l'aveva l'altro e viceversa. Il cognome Scatoletti poi era facile da ricordare , tanto bizzarro e unico in tutto il mandamento. Un motivo però c'era: era un cognome da ospedale, cioè gli era stato attribuito nel brefotrofio annesso, alla cui ruota era stato portato. Era un neonato piccolissimo, consegnato in una scatola da scarpe, da qui il cognome. Non è che la suora addetta a ricevere i bambini lasciati alla ruota avesse una gran fantasia nell'attribuire i cognomi, lo si può notare dai registri della Casa Esposti, dove compaiono altri cognomi stravaganti. Certo con Scatoletti si era superata. Occorre però anche capirla, perché in quel brefotrofio entravano 300-350 bambini e bambine all'anno, praticamente in media uno ogni giorno, quindi c'era da esercitarsi bene per inventare i cognomi. Comunque Scatoletti fu quasi un presagio: rimase minuto di corporatura anche da adulto.
Anche l'Argia proveniva dalla Casa Esposti, ma nel suo caso il cognome lo conoscevano solo all'anagrafe.
Certo, a pensarci bene, il fatto di non conoscere né il padre, né la madre doveva essere un limite non indifferente, anche se comune a tanti altri bambini nelle loro condizioni di nascita. I genitori naturali potevano essere benestanti, modesti artigiani, donne al servizio di case di possidenti ricchi; magari li avevano concepiti fuori del matrimonio; forse erano preti o suore, o magari famiglie poverissime che non erano in grado di sfamare un'altra bocca. Quasi mai piccoli agricoltori, perché anche se vivevano di stenti, qualcosa da mangiare c'era sempre. Questi bambini potevano anche occasionalmente incontrare casualmente uno o entrambi i genitori, ma la segretezza dei dati personali prevista dalla legge, impediva agli uni e agli altri di riconoscersi. Erano rarissimi i casi nei quali la madre si fosse ritrovata negli anni in una condizione economica migliore che la mettesse in grado di riprendersi il figlio, esibendo una parte di una medaglietta o di una moneta di infimo valore, la metà della quale era stata appesa al collo del neonato con un filo di stoffa, prima della consegna alla ruota.
Entrambi i nostri protagonisti erano stati presto collocati presso due famiglie, che li accolsero volentieri, perché la loro ospitalità comportava una piccola entrata a carico della Pia Casa e quindi una rendita certa, anche se modesta, ma certificata in un libretto che l'impiegato dell'Ente aveva consegnato agli accettanti. La rendita durava fino all'età di tredici anni. Poi l'esposto o restava in famiglia per contribuire col lavoro all'attività di casa, oppure usciva e doveva rendersi autonomo, anche economicamente.
Normalmente dopo la frequenza dei primi due anni della scuola elementare, che nei paesi allora era formata da affollate pluriclassi, i bambini venivano avviati al lavoro, per imparare un mestiere.
Scatoletti fu collocato come garzone da un falegname, mentre l'Argiòn presso una casa benestante per svolgere funzioni domestiche, imparare a cucire, far da mangiare, pulire i pavimenti. Ovviamente la retribuzione sindacale non esisteva, ci si doveva affidare al buon cuore dei padroni che molto spesso li retribuivano con qualche derrata alimentare, verdura dell'orto domestico, qualche uovo del pollaio, raramente con qualche spicciolo, che i due badavano bene a risparmiare.
Passati i tredici anni e cessato il compenso del libretto, entrambi dovettero arrangiarsi. Scatoletti aveva imparato sì qualcosa in falegnameria, ma era un lavoro pesante per lui e per di più il padrone, con la scusa (vera) delle annate grame, non se la sentì di tenerlo in bottega e dargli una retribuzione. Dovette quindi mettersi a disposizione come operaio agricolo generico a chiamata giornaliera. Anche questa condizione però non era agevole per lui. Innanzitutto gli agricoltori possidenti preferivano chiamare a giornata persone che disponevano di un fisico più adatto agli sforzi ; inoltre si poteva lavorare nella bella stagione e non sempre tutti i giorni. Grazie al suo carattere docile e sottomesso (e poteva comportarsi diversamente?), Scatoletti qualche giornata di lavoro la rimediava, ma era una vita di pura sussistenza, una lotta giornaliera per poter sfamarsi. Diligentemente ogni mattina andava nella piccola piazza del paese, insieme agli altri operai giornalieri, sperando che qualche benestante avesse bisogno di manodopera e non sempre veniva chiamato. Figuratevi poi nella stagione invernale, nella quale i lavori agricoli erano pressoché fermi e il freddo tanto. La fame però non mancava. Gli era toccato qualche volta di andare per elemosina nelle case di benestanti o di semplici agricoltori per rimediare qualcosa da mangiare o la possibilità di poter dormire sul fienile o nella stalla, dove almeno il caldo era assicurato. Aspettava, come altri, le feste natalizie. Era consuetudine infatti che, nella loro imminenza, nelle case degli agricoltori o in quelle dei più benestanti bussassero alla porta tanti nella condizioni di Scatoletti, per aver qualcosa. Pochissimi chiudevano la porta in faccia; si trattava non di denaro, ma di una sessola di farina bianca o, più frequentemente gialla, per fare la polenta, qualche patata, qualche uovo. Anche l'Istituto Elemosiniero, nato dalle donazioni di tanti possidenti, in quelle ricorrenze elargiva qualche denaro o derrata a chi era più povero: c'era la fila davanti alla porta dell'Ente in quei giorni. Uno spettacolo che chi lo vedeva, non se lo dimenticava più di certo. Tutte queste elargizioni (vogliamo chiamarle così?) erano poi soggette alle annate, che non raramente erano magre, vuoi per le inondazioni, vuoi per le avverse condizioni atmosferiche, per le forti grandinate, vuoi per altri accidenti che purtroppo non mancavano.
Per l'Argìa le cose andavano meno peggio. Era riuscita ad essere accolta in una casa benestante, dove faceva da serva (allora si diceva così), lavori umili, pulizie, cucina, pollaio, orto. Soldi ne vedeva assai pochi, ma almeno qualcosa mangiava, insieme all'altra servitù, maschile e femminile, che si poteva sedere a una tavola, posta in uno sgabuzzino nel retro della casa. Ovviamente quando era già terminato il pranzo dei padroni ed erano state sbrigate tutte le faccende. Quindi era riuscita ad avere almeno le due cose primarie: mangiare e un letto per dormire.
Fu proprio in una primavera nella quale, per lavori straordinari nel palazzo, erano stati chiamati diversi lavoranti, che l'Argià scambiò qualche parola con Scatoletti, chiamato tra gli altri a svolgere i lavori di fatica. Non erano proprio lavori adatti a lui, ma c'era bisogno di molta manodopera e quindi anche Scatoletti era stato chiamato. Riuscì a farsi benvolere, grazie anche alle abilità acquisite nella falegnameria. L'origine comune dei due era stata un pretesto per scambiare qualche parola, badando bene però a non farsi sorprendere a perdere tempo; le conseguenze sarebbero state dannose per entrambi.
Era nato un amore: non avevano diritto anche loro a provare quello che provavano gli altri? Già, ma l'ostacolo era il matrimonio. Senza un'entrata stabile minima, senza una casa, con scarsissime risorse, come fare? Non potevano nemmeno recarsi al Monte di Pietà a chiedere a prestito una piccola somma di denaro almeno per due lenzuola e una coperta. Cosa potevano dare in pegno? Nulla.
Una sera d'inverno però Scatoletti, vedendosi chiusa la porta dal Monte di Pietà, ubicato nel capoluogo, dove si era recato a piedi, a 6 km di distanza, si fece coraggio e andò, col cappello di pezza in mano, a bussare alla porta di don Arturo, il parroco del paese, per chiedere un consiglio. Il giovane parroco non aveva un gran bel carattere e affrontò lo Scatoletti un po' di malavoglia. Disse che non aveva soluzioni e poi quanti in paese si trovavano nelle condizioni del richiedente? Non poteva aiutare tutti. E' vero, c'era l'associazione di San Vincenzo, ma non poteva trovare risorse per aiutarlo a sposarsi. Ci restò male il povero Scatoletti. Dopo poco non ebbe più parole e salutò con un “Riverisco, signor parroco”.
Don Arturo però aveva l'animo del secondo figlio della famosa parabola evangelica. Il primo, su richiesta del padre di andare a lavorare nella vigna, rispose di sì, ma poi non ci andò. Il secondo si arrabbiò, rispose di no malamente, ma poi, pentitosi, assolse alla richiesta del padre. Il parroco meditò quella sera, era ben consapevole che anche lui era nato nelle condizioni di Scatoletti, solo che era stato più fortunato. Nei giorni successivi chiamò in casa parrocchiale i fabbricieri, la presidente della S.Vincenzo. Si consigliò con un parroco anziano del paese vicino. Dopo qualche giorno, mandò a chiamare Scatoletti.
Questi, sempre col suo bravo cappello in mano, si presentò timoroso di andare incontro più a una delusione, se non a un forte rimprovero (quanti gli avevano dato del matto, perché voleva sposarsi?), che non con in tasca una speranza. Invece don Arturo gli disse che qualcosa la S.Vincenzo avrebbe trovato, non soldi, ma qualche capo di biancheria, qualche stoviglia. Inoltre un fabbriciere, sollecitato dal parroco, avrebbe messo a disposizione, senza chiedere affitto, una stanza modesta, molto modesta, vicino al porcile e al forno del pane, al solo piano terreno. Era un ricovero di attrezzi agricoli, ma la sua famiglia se ne sarebbe privata volentieri, pur di fare un'opera di carità. Scatoletti ringraziò calorosamente; non gli pareva vero. Era sera, ma non stava nella pelle e si recò alla porta del palazzo dove era l'Argìa. Dovette aspettare fuori un bel po', perché la padrona non le permetteva di uscire, fino a che non avesse finito tutti i lavori.
Quando uscì, d'un fiato le comunicò l'esito del colloquio col parroco, ma fu una comunicazione di pochi minuti, sufficienti però a mettere in subbuglio il cuore dell'Argìa.
La padrona, con la scaltrezza che le era propria, confessò la ragazza, ma non ebbe una reazione negativa, come si aspettava l'Argìa. In fondo (anche se un po' in fondo) non era una persona cattiva.
Il mattino dopo chiamò di nascosto la ragazza in una stanza fuori mano e le disse che qualcosa aveva pensato, per aiutarla. Sarebbe andata il giorno stesso nel capoluogo, dove conosceva il presidente della Congregazione di Carità, che comprendeva anche l'Istituto Elemosiniero e Dotale, che tra le sue funzioni aveva anche quella di fornire una dote, pur se modesta, alle ragazze di buoni costumi, ma prive di qualsiasi disponibilità economica. Avrebbe avanzato la domanda, ma l'Argìa doveva impegnarsi a continuare il lavoro di sempre nel palazzo. Figuratevi se la ragazza poteva rifiutare!
Detto e fatto. La padrona poi non mancò di chiedere un incontro a don Arturo, il quale confermò quanto aveva promesso a Scatoletti.
Per farla breve, un mese dopo, un mercoledì mattino presto, alla messa delle sei del mattino, i due si sposarono. Non c'erano i parenti che non avevano, non c'erano i fiori che non potevano acquistare, non avevano gli abiti della cerimonia, perché avevano solo pochissimi vestiti e di seconda o terza mano, non si scambiarono gli anelli, perché non erano nella condizione di comprarli, ma don Arturo benedì le loro nozze, attorniato dai suoi chierichetti, vispi e irrequieti, anche se obbedienti ad una sola occhiata del prevosto. L'Argìa, che non era una bellezza sfolgorante, ma era ancora magra, era raggiante. Il sagrestano e la padrona fecero da testimoni. Il parroco non si fece pagare nulla, tutti firmarono il registro dei matrimoni. Perdio, sapevano leggere e scrivere e non avevano bisogno di apporre la croce degli analfabeti! Andarono a piedi nella loro stanza che sarebbe diventata la loro casa. Non ebbero il tempo di festeggiare, ma andarono quasi subito al lavoro.
Il falegname presso il quale Scatoletti aveva fatto da garzone, aveva costruito un letto rustico con delle assi e con altre fece un piccolo tavolo e li regalò al suo vecchio garzone. La padrona regalò qualche vecchia suppellettile che nel palazzo era stata messa fuori uso.
La casa-stanza era infelice, caldissima d'estate e gelida d'inverno, ma per loro era un sogno. Nell'avvicinarsi dell'autunno lo sposo costruì, con l'aiuto dei proprietari, un piccolo focolare con canna fumaria, che dire camino era un po' esagerato. I proprietari poi, ogni tanto, facevano portare dai bambini di casa, qualche uovo del pollaio, qualche forma di pane quando lo cuocevano nel forno e Scatoletti si rendeva disponibile ad aiutare in qualche lavoro agricolo, ottenendo in cambio la possibilità di raccogliere un po' di legna quando in inverno venivano capitozzati i pioppi dei rivali.
Vivevano certo una vita di stenti, ma non vollero mancare di dare il loro contributo modesto alla sottoscrizione per la costruzione della nuova chiesa del paese. Il registro degli offerenti, con i nomi e le cifre accanto, che don Arturo compilò scrupolosamente, sono ancora là a testimoniarlo.
Abitarono quella casa per più di vent'anni. Quando non furono più in grado di reggere, il Comune li accolse nell'Ospizio di Mendicità, dove morirono molto presto, prima lui, poi lei, dando così al Comune un onere leggero.
Quando osservo ancora quella stanza, oggi adibita a ricovero dei bidoni dell'immondizia, con le pareti annerite dal fumo, col caldo soffocante quando vi si entra d'estate e il fiato che pare fumo d'inverno, mi chiedo ancora come possano avere vissuto una vita così. Eppure per loro fu la felicità. Incomprensibile oggi, ma, come spesso accade, ciò che appare non sempre è la realtà.