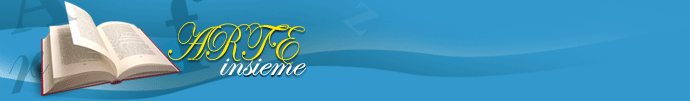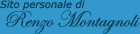Note sui canti VI e IX del Paradiso commentati dal prof. Nicolò Mineo, e Note capricciose sull’Ulisse dantesco, a cura di Giuseppe Piazza
Note sui canti VI e IX del Paradiso commentati dal prof. Nicolò Mineo, e Note capricciose sull'Ulisse dantesco.
A cura di Giuseppe Piazza
Capita in questo percorso di letture del Paradiso, condotte con profondità di analisi da parte del prof. Nicolò Mineo, di recuperare antiche impressioni culturali sulla operosità intellettuale e poetica di Dante nel suo confronto reale e storico con il proprio tempo, e chiedermi se mai egli avesse considerato tale rapporto con ottica diversa da quella teologico-imperiale, riflessione questa che mi è sorta proprio dopo la lettura del VI canto del Paradiso, con al centro Dio e la Chiesa congiunti in un “rapporto di sostanziale identificazione con la volontà del cielo, a cui tende tutta la storia precedente e a cui guarda tutta la storia successiva, significata dal volo dell'Aquila imperiale, che investe anche il tempo terreno di Cristo” come scrive il critico. Ma l'Impero universale a cui guarda Dante nella sua realtà storica si era già frantumato dopo la morte di Carlo Magno con la nascita dei nuovi stati europei ad opera dei suoi successori, e la Chiesa appariva lacerata da interessi terreni in cui stentava a sopravvivere. In questo frangente storico politico, giusto mi pare allora quel giudizio che vuole scolasticamente Dante Laudator temporis acti, e di rincalzo presumere la fattività culturale di questo mio Pensiero, per riportare il Poeta nella vita reale di quella storia e per esso credere anche di poter dare un nuovo senso alle sue mirabili utopie, da sentire come un fertile racconto della presenza costante dello spirito umano, che fascinosamente attraversa il proprio tempo buio:
Dante, a parte, la sua grandezza di stile e di lingua e quella di creatore di rappresentazioni lirico-drammatiche inarrivabili è, in sostanza, un poeta conservatore, non solo perché continua a misurarsi con gli ideali del passato cortese e feudale, ma perché non anticipa alcuna nuova visione storica della vita, e non sa accettare quella società della nuova gente, che andava creando una civiltà dinamica e cosmopolita. Non si accorge e non sa comprendere, se non in funzione di povertà francescana, i moti pauperistici, i contrasti e le violenze cittadine come un segno della nuova civiltà comunale, dominata dai conflitti economici e sociali, sempre più politicamente accentuati, di cui anch'egli resta vittima. Uomo interamente del suo tempo, e come tale rese la visione della vita tutta dentro la religione cristiana, e per questo non seppe né poté proporre nuovi sistemi di pensiero politico e morale, fuori dal cattolicesimo imperiale e papale dominanti, che, a ben considerare, ci appaiono privi di ogni afflato interumano, rispettoso e lieto di confrontarsi con la libertà e le scelte etiche e religiose degli altri. E le Cantiche soprattutto ne portano i segni discriminatori nel pregiudizio della vera ed unica fede.
Giuseppe Piazza
Giarre,25-11-2020
Riflessioni sul IX canto del Paradiso
E seguitando la rilettura del IX canto del Paradiso sulle orme stringenti del commento del prof. Mineo ci si può anche occasionalmente imbattere in riflessioni che portano a ripensare la dottrina morale della Chiesa a proposito del perdono dei peccatori, quale domina soprattutto nel Purgatorio, che per la grazia del pentimento e della confessione riescono ad acquistare meriti paradisiaci, come appunto è successo anche alle tre anime incontrate nel cielo di Venere, Cunizza da Romano, esemplare in vita per la scandalosità dei suoi comportamenti lussuriosi, tanto che anche in tarda età non si negava a chi la richiedesse; Folchetto da Marsiglia, che si pente dei propri traviamenti, ed infine la gentile ed umbratile figura della meretrice Raab, ricordata come meritevole di perdono per il suo aiuto prestato agli esploratori di Giosuè nella presa di Gerico, che aprì la strada alla conquista della Terra Promessa. Ma quello che di più mi ha ricordato la situazione di salvezza di questi personaggi, è che la loro sorte morale può anche inserirsi nelle ampie meditazioni sulla salvezza affrontate nell'Augustinus da Giansenio e rivedere il loro comportamento, di certo lontano dall'inflessibile rigorismo stoico, in quel dibattito tra giansenisti e gesuiti sul perdono delle colpe che per la Chiesa avveniva per mezzo della Frequente Comunione, come volevano i Gesuiti, sostenendo che più si era sprovvisti di Grazia più ci si doveva avvicinare arditamente a Gesù Cristo e all'Eucarestia, affermazione questa che dava occasione ai giansenisti di attaccare il lassismo morale dei gesuiti e ribadire il valore della Grazia e della Predestinazione di stampo agostiniano, a cui anche il Manzoni guardò con simpatia. Quali siano stati i motivi politici e dottrinali che fecero fallire e condannare il Giansenismo nella Francia di Luigi XIV con la conseguente distruzione dell'Abbazia di Port Royal non ho sufficienti informazioni culturali per trattare di tale argomento, premendomi solo ricordare che la pratica della Frequente Comunione era stata anche corretta dalla stessa Chiesa, nel concilio di Trento, consigliando la confessione solo una volta all'anno, mentre su tale versante il giansenismo non ebbe fortuna nonostante che in esso operassero principi democratici quando si ricorda icasticamente che “Bisogna pregare come se tutto dipendesse da Dio, e agire come se tutto dipendesse da noi”, sentenza che ci rimanda a Pascal e a Calvino per l'alta intellettualità teologica e morale che vi si affronta, in bilico tra Grazia e Predestinazione, il cui assunto, forse, non era il problema assoluto dell'agire morale e politico dell'uomo di Dante.
24-dicembre- 2020
Su un modo stravagante e capriccioso di leggere l'Ulisse dantesco, come un appunto che vuole andare a frugare oltre la lettera dell'alta critica, che ama vedere cogli occhi inebriati del padrone di casa.
Ora veniamo alla questione. E' un abile panegirico quella “picciola orazione” di Ulisse rivolta a spingere e persuadere i suoi compagni, vecchi e tardi, a tentare la conoscenza del mondo che si apre di là, dove si distilla ancora il pianto deluso di un Alessandro Magno sulle rive dell'Indo. Le parole di quel discorso vengono a cadere intenzionalmente nella contrapposizione tra mondo cristiano, fatto di virtù e conoscenza e quello dell'Ulisse del mito, quello in cui l'uomo è stato un bruto. Così in premessa vengono segnati i confini morali da agevolmente sviluppare in exemplum edificante, che vede di fronte il mondo dove l'uomo è stato un bruto e quello cristiano, dove l'uomo si veste di qualità spirituali negate al mondo di Ulisse, apparendo solo le qualità esclusive del mondo dell'etica cristiana con concetti esaltati, specie quello della conoscenza, già nel Convivio. E procedendo nella lettura scopriamo che Dante riveste Ulisse di una funzione alquanto ambigua, quando sollecita i suoi compagni a non vivere più come bruti, ma a seguire virtù e conoscenza, di cui egli, antico e pagano , e quindi bruto , si farebbe paradossalmente banditore, come se già egli solo ne fosse in possesso alla guisa dei moderni evangelizzatori. A ben presumere ci pare che Dante in Ulisse avesse voluto profeticamente anticipare degli atteggiamenti spirituali nuovi, che furono poi del pensiero rinascimentale, attribuendo anche quelle qualità di virtù e conoscenza al mondo antico anziché alla sola etica cristiana in cui tutto è finalizzato alla salvezza e alla conoscenza. Infine come potrebbe mai Dante ,uomo della rivelazione e della conoscenza cristiane, attribuire le parole che fa dire da Ulisse ai suoi compagni “ fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”, se solo più tardi nell'attuazione della rivelazione cristiana già si sarebbe compiuta ogni conoscenza e virtù, che qui appaiono prefigurate ed operanti in Ulisse, presentato come un precorritore di quella rivelazione? Dante nell'episodio di Ulisse, sotto la specie di mostrare un esempio negativo, per quella imprevedibile complessità psicologica di felice contraddizione ha forse detto ciò che non voleva dire, chiamando bruti gli uomini cristiani con il pretesto di chiamare bruti i compagni di Ulisse. Del resto però non è possibile immaginare che Dante volesse attribuire quelle parole anche contro i cristiani e contro tutto il mondo antico fino al precristianesimo e quindi anche a Virgilio e a tutti i grandi spiriti confinati nel Limbo, solo perché in essi la conoscenza è stata “senza frutto”. Ma a che scopo allora fare dire ad Ulisse che i suoi compagni sono nati per seguire virtù e conoscenza, se tali qualità sarebbero rimaste ancora lontane ed invisibili prima dell'avvento del Cristianesimo e della rivelazione della verità ? Per cui ci pare che Dante abbia intenzionalmente camuffato la vera natura intellettuale di Ulisse per non farci vedere che quelle qualità cristiane erano state anche virtù degli antichi spiriti, brutalmente sprofondati nel Limbo, ove oscuramente dimora anche il suo Virgilio, che come pagano non era obbligato ad antivedere e a seguire il catechismo cristiano, che imponeva di trovare solo in esso la grazia della virtù e della conoscenza.